
Qui, nel carcere di Ivrea, grazie ad alcuni Agenti del personale di Polizia Penitenziaria, fui segnalato e proposto come scrivano e successivamente, anche come volontario bibliotecario.
Già in passato, moltissimi anni fa, in altro carcere sempre in Piemonte, svolsi per anni le attività lavorative come bibliotecario e scrivano e quindi avevo già una discreta preparazione in merito, ricevendo complimenti da avvocati e non, per come impostavo e formulavo, in base agli articoli di legge, le istanze alle varie e diverse autorità.
All’epoca, leggevo molto per motivi personali il codice di procedura penale, codice penale e ordinamento penitenziario: avevo sulle spalle una condanna lunghissima e volevo sapere, conoscere e apprendere le varie leggi e il cosiddetto pensiero giuridico, per poi avanzare istanze a mio favore.
Tenevo sempre e scrupolosamente pulito, in ordine, e i libri ben catalogati e, per quanto fosse in ordine un numero considerevole di libri, a volte, guardando gli scaffali, provavo come una sensazione di disordine: che quel romanzo non fosse al suo posto, quel libro di poesie forse si trovava sullo scaffale sbagliato e così via; avvertivo un qualcosa in me che mi suggeriva insistentemente di mettere in ordine.
Era tutto in ordine.
Sicuramente, mi faceva questo effetto perché mi mancavano ormai ancora un paio di anni per pagare per intero il mio debito con la giustizia e verso la società e sarei ritornato ad essere un uomo libero.
A pensarci oggi, direi che quel disordine che io “vedevo” nella biblioteca era in realtà dentro di me, quasi una sorta di introspezione inconscia, come a volermi dire cosa e come dovevo comportarmi una volta fuori dal carcere: tanti progetti, i sogni a occhi aperti, tante speranze mi balenavano per la mente.
Ero talmente sicuro e convinto di tutta la mia buona volontà di riprendermi la mia vita e godermela attimo per attimo che non presi neppure in considerazione il fatto che quando avrei varcato quel cancello da uomo libero, non avrei avuto un posto in cui andare a dormire, mangiare, lavarmi, ripararmi e per di più in una località a me sconosciuta, senza amici né conoscenti.
Ero troppo euforico, eccitato e andavo in palestra a scaricare tutta quella adrenalina; mi esercitavo con la chitarra; mi dedicavo alla biblioteca, alle varie istanze; la sera mi cucinavo: non stavo mai fermo.
Il solo pensiero che da lì a poco sarei uscito e sarei ritornato nuovamente in seno alla società, mi faceva sognare ad occhi aperti.
Le priorità da dare a questo o quel progetto; dove e come trovarmi un lavoro e vivere onestamente; trovarmi una compagna che mi amasse ed accettasse per quello che ero, con la quale mi sarei ricostruito una famiglia, un proprio nucleo familiare in virtù di un futuro sereno e tranquillo e, soprattutto, lontano e alla larga dai guai.
Non mi passava neppure più per la mente di rientrare nel “giro” o riprendere certi vecchi contatti: avevo fatto e firmato un “contratto” (Art. 58 Ter: collaboratore di giustizia) con la giustizia.
Successivamente avrei rifiutato il programma di protezione speciale per essere stato deluso profondamente dalla stessa giustizia e non volevo più saperne niente.
Volevo solo riprendermi la mia vita e lasciarmi alle spalle quel passato: il passato di malavitoso e quello di collaboratore di giustizia.
Non volevo più essere etichettato; volevo solo, come dissi a un Presidente di una Corte che mi vedeva come testimone contro un altro collaboratore di giustizia sotto programma di protezione, “farmi dimenticare dalla malavita e giustizia”.
Dichiarazione che fu messa agli atti anche per volere dello stesso Presidente il quale mi disse che il mio era un motivo più che valido.
Forse era sicuramente questa la visione di quel disordine che vedevo in quella biblioteca.
Ma non l’avevo capito.
Tutto cambia, passa e va!…
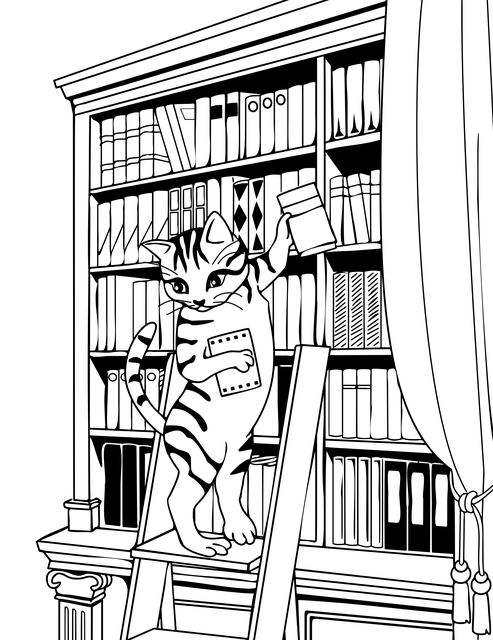
Ora, a distanza di molti anni, questa biblioteca nel carcere di Ivrea, per quanto ordinata, pulita e con scaffali di libri ben catalogati, o quasi, in cui presto la mia attività come volontario, non mi suscita più quella stessa sensazione di disordine, di ansia; né più il pensiero di farmi progetti futuri, o sperare e sognare ancora una vita da uomo libero; avverto una certa quiete interiore.
Speranza: è bellissima e profonda questa parola, ma altrettanto vuota, priva di significato per me.
Fra tutte le carcerazioni del passato, in questa, per la prima volta e con profonda tristezza, devo ammettere che in questa biblioteca, di questo carcere, tutto mi sembra al posto suo: io sono nel posto giusto… .
Di riflesso, istintivamente, guardo gli scaffali e ripiani dei libri e guardo e scruto dentro di me e vedo invece una sorta di resa, di rassegnazione, con una reale consapevolezza e, con un pizzico d’amaro nel cuore il mio pensiero è: “come i libri che devono stare sugli scaffali, qui, al proprio posto, in attesa che qualche altro detenuto venga a prenderli, io devo stare qui, rinchiuso in una piccola cella, avvolto in un’attesa indifferente dal tempo che scorre via lentamente, quasi statico, mentre il mondo e la vita al di là del muro di cinta cambiano e si evolvono velocemente.
La società ignora la mia esistenza e la giustizia mi ha scaricato qui, in questo sempre più abbandonato “carnaio umano,” dove tutto ti è permesso (pensare) ma niente ti viene concesso: qui non hai patria né bandiera; sei soltanto un numero di matricola; e, come i libri sugli scaffali, io passivamente, resterò qui in attesa forse dell’ultimo respiro, perché nessuna mano mai si allungherà in avanti verso di me.
Questo triste, penoso e funesto pensiero, pregno di profonda solitudine e corali pentimenti, come una saetta a volte si fa spazio con prepotenza nella mia mente.
Solitudine in vita e in morte.
Sicuramente il tutto scaturisce dal fatto che devo ancora imparare a maturare il pensiero di perdonarmi, di fare pace con me stesso. Non è facile.
Ho ucciso una persona senza un perché, senza un motivo, se non quello apparente dei soldi, di quello sporco e maledettamente comodo motivo del dio denaro, e ho distrutto non solo la mia vita, ma cancellai i colori dell’amore dal cuore di colei che mi aveva accettato per quello che ero: mi aveva reso un uomo libero.
“Non lo voglio più sentire: per me è morto!”, mi mandò a dire la stessa donna dal mio Avvocato,
dopo una settimana, dieci giorni dall’arresto.
Lei, come molti, non lo sa: io cessai di vivere ancor prima di quel suo messaggio, nel momento in cui presi coscienza e consapevolezza di ciò di cui mi ero reso tristemente protagonista, e se non sono ancora fisicamente morto, lo devo a quella traditrice e meretrice della morte, la quale, ancora una volta, mi “sputò” in faccia…
Io stesso, come un masochista, sono complice accondiscendente di questa mia resa e rassegnazione, e quasi indifferente alla mia stessa vita.
Consapevole mi lascio trasportare in silenzio sempre più in quell’abisso buio della solitudine e dell’abbandono, e di quel pensiero che ogni tanto si fa spazio nella mia mente: “farla finita…”.
Quando quelle poche volte mi capita di parlare con qualche persona che non sia un detenuto, mi tengo sulle mie e parlo senza dire niente; non mi piace essere compatito per il solo fatto di essere un detenuto, un detenuto e basta; uno dei tanti “poveri” diavoli in questo inferno e alla domanda ”come stai?”, con un sorriso sulle labbra rispondo sempre: “bene, grazie…”.
Non mi piacciono quei “colloqui” freddi e distaccati e “tecnici” di circostanza e comunque, non apro a loro i miei fatti personali e intimi.
Forse non è per sfiducia, ma il fatto stesso che ci vediamo oggi, di sfuggita, per farti redigere una relazione e poi chi s’è visto s’è visto, trovo che non sia il modo migliore di seguire, conoscere ed aiutare concretamente un detenuto.
Sono anni ormai che mi sono chiuso in me stesso: quante volte mi sono rivoltato come un calzino,
facendomi delle introspezioni a tu per tu con la mia coscienza di uomo in cerca di risposte, di chiarezza, e d’impulso, quasi autopunitivo, mi lascio andare alla sorte passivamente: “mea culpa”, faccio dentro di me.
Quando esco fuori dalla cella e arrivo alla rotonda per andare in biblioteca o in “laboratorio,” mi faccio vedere sempre o quasi sorridente, tranquillo e cordiale: non devono sapere, nessuno deve sapere quello che mi porto dentro in silenzio.
La vergogna e pentimento che mi porto dentro non voglio condividerla con nessuno, e parlarne, mi
fa star male il solo pensiero.
A volte mi capita di guardare fuori dalle sbarre della finestra e vedo case, edifici, automobili, o qualche persona che passeggia insieme al suo amico fedele a quattro zampe e non provo e non sento più quel sentimento di nostalgia per quel mondo al di là da queste mura: mi è tutto indifferente, quasi fosse morto, come io per lui.
Quel ponte che un tempo ci univa è crollato, non c’è più: l’ho distrutto con la mia stupidità in un
momento di follia.
Benché siano trascorsi molti anni, quel ponte non mi riesce ancora di visualizzarlo con gli occhi
della mente. Non lo vedo più.
Questa forse la causa principale di non avere più un buon rapporto con me stesso.
Mi viene a volta da pensare in modo quasi dubbioso se io sia mai esistito prima, per qualcuno, con
qualcuno.
In conseguenza al “meccanismo di difesa” che la mia mente ha adottato, rimuovendo il tutto di quel
mio barbaro crimine e di tutto lo scenario del contesto del paesino in cui vivevo, ho coniato forse io
la seguente frase, o forse devo averla letta o sentita da qualche parte, non lo so, non ricordo, ma
sento che è una frase partorita dal mio cervello, dal mio stato d’animo d’abbandono di quel
momento: “non sto bene, ma sto bene come sto…”.
Questo scherzo che la mia memoria mi ha fatto e continua a farmi, tutto sommato mi sta aiutando,
per adesso, a sopravvivere, e vivo così, senza ricordi.
Quasi come se non avessi vissuto certi momenti, certi periodi; a volte, quando ci penso e per un
motivo o per un altro, con non poca fatica mentale, cerco di rievocare alla mente determinati
episodi, fatti, cose o addirittura volti di persone a me care e non affiorano, mi sento come se fossi
vuoto, come se non avessi un vissuto passato.
È triste quando ci rifletto sopra, ma nel contesto della triste e penosa situazione in cui mi trovo, non
mi lamento, non ho nulla di cui lamentarmi: fui arrestato, giudicato, processato e condannato; non
fui messo davanti ad un plotone d’esecuzione e fucilato.
Mi rinchiusero in una piccola cella di un carcere e come condanna mi decurtarono dalla mia vita 20
anni: questa la punizione, ma non mi ammazzarono fisicamente come io purtroppo, feci con la vittima; no, credo invece che sto bene come sto.
Sono solo, non ho più nessuno, non ho più una famiglia, non faccio colloqui, non scrivo e non
ricevo, non telefono a nessuno e lì fuori, al di là di queste sbarre, non c’è nessuno che mi aspetta o
sta in pensiero per me.
Penso però a volte alla famiglia di quel giovane uomo da me ucciso che non hanno più un figlio;
bene o male, qui in carcere, vero o falso, un abbraccio lo ricevo, ma quella famiglia non potrà mai
più riabbracciare il proprio caro.
Ancora oggi, a distanza di anni, ho una fottutissima paura di chiedere perdono, come avrei invece
dovuto fare all’inizio, quando mi resi consapevole, ma la profonda vergogna e sensi di colpa me lo
impedirono. Mi suonava come una sorta di offesa e per la memoria della vittima e per la sua famiglia.
Il perdono, il perdono non cancella, non cancella niente e non restituisce niente: rimane sempre e
comunque una crepa invisibile incisa sul cuore.
Come posso e con quale autorità perdonare me stesso per un crimine barbaro e vergognoso che vive
pesantemente come un’onta nella mia coscienza di uomo?
In questa biblioteca che è diventata ormai da anni il mio rifugio, trascorro il tempo scrivendo la mia
storia; dovrei invece leggere per tenere la mente allenata e per aprirmi a nuovi orizzonti; ci ho provato qualche volta, ma evidentemente non sono mentalmente sereno e faccio fatica a recepire e quindi trovo sfogo nel mio passato: lo stesso passato che ora mi vede e tiene qui.
Sicuramente per me il carcere è la conseguenza delle delusioni, solitudini e sconfitte che la vita mi ha sbattuto in faccia fin dall’infanzia e, non potevo che prendere, nel corso della vita, scelte e percorsi fuori da ogni regola sociale.
L’istituzionalizzato





