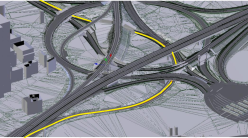Frammenti di vita
Credo che ognuno di noi nel lungo tragitto della propria esistenza, per un motivo o per un altro, prima o poi senta il bisogno di fare un bilancio della propria vita, cercando di mettere un po’ di ordine ai ricordi; magari, mentre stai pensando e rievocando, qualcosa salta fuori a sorpresa, proprio come succede aprendo dei cassetti: ne apri uno, poi un altro e un altro ancora e inizia così un sofferto e faticoso lavoro mentale che ti porta a vedere gli eventi con occhi diversi.
Dopo una travagliata riflessione, ho deciso di rendere pubblico, attraverso questo racconto, una parte della mia storia: non soltanto le innumerevoli disavventure avute con la giustizia, ma anche e soprattutto quella vita privata che pochi, pochissimi delinquenti e assassini raccontano.
Probabilmente questo mio pensiero scaturisce e nasce proprio dal mio ultimo crimine, un delitto barbaro e crudele per il quale oggi, a distanza di anni, devo ancora fare pace con me stesso. Sono molto restio a parlarne, provo vergogna e quasi non mi riconosco più, non mi identifico in quell’assassino spietato e crudele che spezzò quella giovane vita.
Non esiste alcuna giustificazione quando si uccide un proprio simile.
Voglio condividere con altri tutte quelle esperienze di vita che, dall’infanzia, all’adolescenza, fino ad oggi, mi plasmarono e non da meno, mi preme far conoscere quale storia difficile, si nasconde, a volte, nel cuore e nella mente di un assassino.
Credo fermamente che nessun essere umano nasca delinquente o assassino e nessun uomo si alzi un mattino col pensiero di uccidere un suo simile.
I familiari delle vittime giustamente vogliono sapere “perché”, gridano e si disperano per conoscere la verità, quasi a voler rivivere, attraverso le parole e gli sguardi del carnefice, gli ultimi istanti di vita della persona amata.
Nel mio caso, non ci sono parole, non esistono frasi di “conforto” e, nulla che possa restituire quella perdita. Potrò sembrare cinico, ma nessuna parola che accompagni il pentimento riuscirà mai, per quanto veritiera, a colmare, nemmeno in minima parte, quel vuoto che i loro cuori hanno dentro per colpa mia.
Ho ucciso e sono uno sporco assassino privo di ogni scrupolo.
Questo sono: un assassino, un assassino recidivo, già nel 1980, quando evasi dal carcere di Bologna e mi diedi alla clandestinità, compiendo numerosi e vari reati, in un aspettato e non voluto “duello”, avevo sparato e ucciso.
Questa è la testimonianza della mia vita, o meglio, di quella infanzia che mi plasmò nel corso degli anni: la mia infanzia, che determinò tutto e fece di me quello che sono.
Una storia simile a molte altre storie di malavitosi e assassini, e che non auguro a nessuno.
Per quanto, in cuor mio, sia pur in vecchiaia, vorrei darmi un’ultima chance e ritornare ad essere padrone della mia vita, della mia esistenza, della mia libertà di uomo, che ha sbagliato, ma che sta pagando. Ora proprio grazie alla vittima, vedo le cose sotto un’altra luce.

La vita, la Vita questo mi offrì e, volente o nolente, tutto quanto di bello o di brutto mi è capitato nel corso degli anni, sono comunque piccole e grandi esperienze di una vita allo stato brado, intensa, piena, ingarbugliata.
Oggi, ho davanti a me la quasi certa prospettiva di finire i miei giorni dentro la cella di un carcere.
La cosa non mi spaventa più di tanto e sorella morte dovrà lottare contro un vecchio guerriero che porta dentro di sé le armi migliori per contrastarla: rabbia, speranza e tanta, tanta voglia di vivere ancora.
Guardo al mio passato per meglio sopravvivere nel presente e per proiettarmi in questo incerto futuro: voglio ancora sperare, sognare, amare, anche solo con la mente.
La solitudine, mia compagna fedele, a sé forte mi stringe, e d’improvviso, la mente mi catapulta indietro nel tempo, squarciando il profondo silenzio della notte che mi circonda, ed ho voglia di riaprire tutti i cassetti e di guardarci dentro fino all’angolo più nascosto.
Da bambino ero germogliato tra preghiere, il credo religioso misto a sofferenze, solitudini e violenze fisiche e assimilavo tutto ciò che mi circondava. Non conobbi favole, e non ebbi amichetti di gioco, non sapevo neppure cosa volesse dire allegria o spensieratezza. Ero un bambino introverso e taciturno e se mi ponevo delle domande, esse morivano dentro me perché non domandavo mai, non potevo, non dovevo, era tabù.
Non era di certo il mio destino. Era il destino consegnatomi dai miei genitori.
Credo che fosse invece il Fato: nell’antica Grecia il Fato era un’entità soprannaturale, una forza cieca e misteriosa, per un verso naturale, alla quale niente può resistere e, per un altro, divina, poiché agisce liberamente, per modificare il corso della vita degli uomini senza alcuna precisa ragione.
I miei genitori entravano e uscivano dal carcere, sembrava quasi che si dessero il cambio: uno entrava e l’altra usciva e, a volte, capitava che fossero entrambi dentro.
La mia infanzia non conobbe quell’amore, affetto, dolcezza e spensieratezza che ogni bambino dovrebbe vivere. L’unico supporto emotivo e amorevole che ebbi, fu soltanto quello di mia nonna: una dolce vecchietta dai lunghissimi capelli argentati e con una leggera gobbetta. Mi piaceva il suo tono pacato e del suo parlare, la sua saggezza e i suoi racconti, le preghiere e i rosari che recitava, le coccole e attenzioni che mi prestava.
Spesso, nell’immaginario collettivo, quando si sente parlare di un camorrista o della sua famiglia, subito vengono in mente droga, armi, estorsioni, spaccio, omicidi, sparatorie, corruzione, clan.
Pur essendo cresciuto in una famiglia di camorristi, mio padre era proprio uno dei camorristi del paese, io non ho mai visto niente (o quasi) di tutto questo.
Pur avendo un cognome “storico”, temuto e rispettato, e avendo fatto parte di alcuni ambienti malavitosi, non ho mai voluto entrare ufficialmente in una “famiglia”, né mai ho accettato di essere “battezzato” come affiliato.
Avevo molte conoscenze e contatti con membri di varie e diverse associazioni mafiose, ma ho sempre voluto essere indipendente, libero di fare e dire ciò che volevo, senza dovermi giustificare o rendere conto a qualcuno; sono sempre stato un cane sciolto e senza padrone; “cane sciolto e onorato” dicevano di me, ossia colui che porta rispetto e si fa rispettare.
In carcere fui reclutato da un altro detenuto, che sarebbe poi diventato uno dei boss di “cosa nostra”, per come guidavo le moto, disarmavo con le sole mani e soprattutto perché, in tutte le carcerazioni subite, non avevo mai aperto bocca, negando anche di fronte all’evidenza dei fatti e iniziai a fare il rapinatore dapprima ai danni dei “Banco Lotti” all’età di 18 anni, insieme a colui che mi aveva reclutato e che sarebbe poi diventato padrino di mio figlio e successivamente, “capofamiglia” di una famiglia emergente di “cosa nostra” degli anni ’80 in Sicilia e a Genova.
Ho sempre mantenuto un profilo basso come malavitoso nell’ambiente: non ostentavo ricchezze di “bella vita” e chi sapeva, o immaginava, stava zitto, anzi doveva stare zitto.
All’epoca c’era ancora una forte e sentita omertà.

Nessuno mi aveva insegnato certe cose: fin da bambino, nel mio paese nativo, guardavo, ascoltavo, obbedivo, portavo rispetto per i più grandi e soprattutto per gli anziani del paese e imparavo; probabilmente quel non mettermi mai in mostra, scaturiva sicuramente dall’immagine che avevo di mio padre.
Non parlavo mai se non interpellato e mai facevo domande, neppure quando le forze dell’ordine mi
portarono via da sotto gli occhi mio padre, mia madre, mio zio e successivamente mia nonna materna.
Fu un susseguirsi di arresti. Difficilmente piangevo e, se lo facevo, piangevo interiormente senza far vedere una sola lacrima. Mi tenevo tutto dentro e anche quando venivo picchiato brutalmente con la cinghia da mio zio, non gli davo la soddisfazione di vedermi piangere; mi limitavo a fissarlo negli occhi, pur sapendo di farlo infuriare ancor di più perché era un segno di sfida.
L’unica persona che non guardavo negli occhi, quando magari prendevo qualche schiaffo, era mio padre, in segno di rispetto e sottomissione.
Lui era mio padre e per quello che mi riguardava, poteva disporre di me come meglio credeva; forse, inconsciamente e con i pensieri di bambino, da grande speravo di diventare come lui.
Per quelli che sono i miei ricordi, non ho mai visto mio padre “esercitare” il suo ruolo di camorrista lì nel paesino, e se lo faceva, non ho mai assistito o visto niente.
Questa mia affermazione non vuole essere una forma di omertà: se lo faceva, lo sapeva fare bene e
senza mettersi in mostra; teneva un profilo basso e cordiale ed era gentile con tutti.
A volte capitava che venisse a casa nostra qualcuno che voleva parlare con lui per chiedergli intercessione per qualche discussione o sgarro che aveva subito; mio padre lo faceva accomodare in sala, chiudeva la porta e nessuno di noi, neppure mia madre, poteva entrare senza prima bussare e ricevere il permesso. Mia madre, e solo lei, poteva entrare per il tempo necessario a posare il vassoio con il caffè sul tavolo; non doveva sentire quello che si dicevano e non poteva essere presente.
A differenza di alcuni affiliati a famiglie che conobbi successivamente a Genova, quando entrai a far parte di un certo gruppo misto, mio padre non portava con sé quelle piccole immagini sacre di santi e santini, così come non l’ho mai visto pregare. Non era credente, ma neppure l’ho mai sentito bestemmiare: quando pranzavamo o cenavamo, si faceva il segno della croce e teneva le dita delle mani incrociate per rispetto verso mia nonna.
Di mio padre ho ancora impresso nella mente, le rare volte in cui era in famiglia e non rinchiuso in carcere, l’impeccabile eleganza: vestiva sempre con completi a tinta unica e gessati, camicia bianca, cravatta, gilet, foulard, un cappello modello “Borsalino” e scarpe sempre pulite e lucide; ben rasato e con espressione quasi sempre seria. Solo quando le circostanze lo richiedevano, faceva una leggera smorfia che voleva somigliare ad un sorriso, mentre quando rispondeva al saluto, lo faceva con quei suoi sorrisetti a zigomi alti.
In un passante anteriore dei pantaloni portava sempre un ciondolo d’oro bene in vista: era un piccolo gobbo (‘o sciò-sciò, come si dice a Napoli). Portafortuna.
Mio padre era di poche parole e con noi figli, parlava ancora di meno; gli bastava uno sguardo, un’occhiata o un cenno del capo per farsi capire.
Non l’ho mai sentito alzare la voce, partecipare a discussioni o litigare con qualcuno; non era tipo
da bar, non giocava mai a carte e mai, in tutta la sua vita, si era ubriacato. In paese tutti ne parlavano bene, anche quando era in carcere a Poggioreale o latitante in Germania, a Düsseldorf, nella “Little Italy”.
Fin dall’età di cinque sei anni, quando vedevo una divisa, vedevo “il nemico”, “l’uomo cattivo”, nei cui confronti nutrivo un profondo e sentito odio, sentimento che mi ha accompagnato fino all’età adulta.
Ricordo che all’età di cinque sei anni, insieme a mia madre, ci alzavamo presto per prendere la corriera che dalla provincia ci portava a Napoli e si fermava proprio davanti all’entrata principale del carcere di Poggioreale. Per entrare a fare un colloquio dovevamo fare delle lunghissime code mentre le guardie controllavano nelle borse che i parenti portavano ai loro cari.
Mio padre era detenuto, non ricordo per cosa.
Non l’ho mai saputo: all’epoca, soprattutto in famiglia, fare certe domande era un vero e proprio tabù. Ho ancora impresso nella mente la volta in cui vidi a colloquio, per la prima volta. Indossava una sorta di “divisa” bianco sporco a strisce grigie verticali e con un numero ben visibile stampato sul petto sinistro.
Mentre trascrivo questo ricordo, mi si affacciano alla mente alcune scene del celebre film “Papillon”: in quel film, i detenuti indossavano delle divise uguali o molto simili.
Mio padre mi teneva sulle sue gambe e, tra una parola e l’altra con mia madre, mi rivolgeva la parola, come a volermi distogliere dal pensiero e dalla visione di quel brutto e squallido posto fatto di sbarre, cancelli, rumori di chiavi, voci che si accavallavano e presenza di agenti (all’epoca chiamati guardie o carcerieri). Proprio in quell’occasione, gli chiesi quando sarebbe venuto a casa,
ma lui con un sorriso, non rispose, guardando mia madre che mi ricordò di non fare certe domande.
Ogni volta, quando il colloquio stava per terminare, vedevo la guardia avvicinarsi a mio padre e dirgli con voce sommessa: <<Don Mattè, il colloquio è finito>>.
In paese avevo già sentito quel “don”, ma ancora non ne capivo il significato; sapevo però che era un titolo che indicava le persone importanti.
All’epoca, il “don” veniva attribuito anche ad Avvocati, notai, sindaci, dottori e a tutti coloro che erano degni di una “investitura”; veniva anche usato come forma di rispetto tra persone non appartenenti o affiliati.
Alle donne ci si doveva “dare” della “commare”, o a quelle di una di una certa età e con voce in capitolo ci si doveva rivolgere con il “Donna”.
Bastava però una parola sbagliata, uno sgarro, un’offesa, per porre fine ad un rapporto amichevole durato negli anni, e quando le circostanze lo richiedevano, in cui l’offeso non era in grado di fronteggiare la situazione, chiedeva l’intercessione del camorrista, e la cosa finiva con le scuse e una bevuta. Quando invece c’era di mezzo l’onore della famiglia, avvenivano veri e propri duelli con le “mollette” (coltelli a scatto), ma non senza il permesso e la presenza del “padrino” (il camorrista).
In questo mio viaggio a ritroso nel tempo, ho rivisto, in quel contesto sociale e familiare del mio paese natale, l’innocenza di un bambino che, tenendomi per mano, mi guidava sul sentiero del mio destino, a me, ancora sconosciuto.
Come poteva, e con quali mezzi, quel bambino innocente, e ancora inconsapevole, essere artefice del mio avverso destino?
Rivedendolo ora, attraverso ricordi che ho trovati in fondo a uno di quei cassetti, con profonda tristezza e tanta tenerezza, comprendo che, non aveva alcuna scelta, né vie di fuga: quella era la sua famiglia, le sue radici.
Ecco, quale storia difficile, si nasconde, a volte, nel cuore e nella mente di un assassino.
L’istituzionalizzato